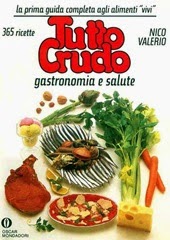Nonostante le critiche, più che i divieti, dei giornali del Regime, la musica dei “negri” e degli americani ebbe grande successo in Italia nell’infausto Ventennio. Tutti ascoltavano e ballavano il “jazz”, vero o annacquato che fosse. Anzi, tanto di moda era quel nome o quel ritmo che ogni musica per avere successo doveva essere “jazz-band”. E i gerarchi? E Mussolini? Bastava dire che si trattava di un valzer o una mazurka. Così, con qualche trucco, lo si suonava e ascoltava perfino dopo le leggi razziali e anti-americane, durante la guerra e nell’Italia divisa. E ci furono addirittura generali della Wermacht e fascisti che organizzarono orchestre jazz. E anche i jazzisti, alla radio (radio Bari contro radio Salò), a modo loro “fecero la guerra”…
Nonostante le critiche, più che i divieti, dei giornali del Regime, la musica dei “negri” e degli americani ebbe grande successo in Italia nell’infausto Ventennio. Tutti ascoltavano e ballavano il “jazz”, vero o annacquato che fosse. Anzi, tanto di moda era quel nome o quel ritmo che ogni musica per avere successo doveva essere “jazz-band”. E i gerarchi? E Mussolini? Bastava dire che si trattava di un valzer o una mazurka. Così, con qualche trucco, lo si suonava e ascoltava perfino dopo le leggi razziali e anti-americane, durante la guerra e nell’Italia divisa. E ci furono addirittura generali della Wermacht e fascisti che organizzarono orchestre jazz. E anche i jazzisti, alla radio (radio Bari contro radio Salò), a modo loro “fecero la guerra”…di NICO VALERIO *
 Villa Torlonia (“Villa Mussolini” per i romani d’allora) riportata al suo antico splendore sembra per una curiosa vendetta della Storia una piccola Casa Bianca, con quell'austero frontone, le colonne neoclassiche e l’ampia scalinata tra i vialetti di ghiaia e il verde. Pare impossibile, scomparso Romano, figlio del Duce e pianista di jazz che vi abitò da bambino, che in questa villa neoclassica dal sapore americano siano potute risuonare nello stesso tempo la voce del capo del fascismo e le note del jazz. Anzi, visto lo stile, forse era proprio il papà ad essere fuori posto, non il figlio.
Villa Torlonia (“Villa Mussolini” per i romani d’allora) riportata al suo antico splendore sembra per una curiosa vendetta della Storia una piccola Casa Bianca, con quell'austero frontone, le colonne neoclassiche e l’ampia scalinata tra i vialetti di ghiaia e il verde. Pare impossibile, scomparso Romano, figlio del Duce e pianista di jazz che vi abitò da bambino, che in questa villa neoclassica dal sapore americano siano potute risuonare nello stesso tempo la voce del capo del fascismo e le note del jazz. Anzi, visto lo stile, forse era proprio il papà ad essere fuori posto, non il figlio. Il jazz in casa Mussolini? Era stato lo stesso Romano a confessarlo: galeotto fu un disco. Già, che ci faceva il 78 giri “afro-demo-plutocratico” Black Beauty del jazzista “negro” e americano Duke Ellington a villa Torlonia, residenza del Duce? Si era nel 1929, e questo era un regalo, non si sa quanto appropriato, di Vittorio Mussolini al fratellino Romano, di pochi anni, che poi sarebbe diventato proprio come Ellington un pianista jazz. E anche il fratello Bruno strimpellava. E qualche volta i figli dei Mussolini facevano dei concertini, ascoltati con ironica benevolenza dal padre, che si dilettava di violino.

Ma il jazz non era vietato dal fascismo? Sì, anzi, no. Per capire quanto il regime, nonostante i toni burberi, fosse di manica larga con la musica di derivazione afroamericana, che non riuscì mai ad estirpare, ecco un eloquente aneddoto raccontato da Nello Di Geronimo, un trombonista jazz così bravo che per anni – racconta lo storico Mazzoletti – i critici credettero che in
Stompin’ at The Savoy, del 1938, a suonare non fosse lui, ma "qualche musicista straniero".
A Gela nel ’36 arriva Mussolini, e la sera trova ad accoglierlo l’orchestrina jazz del giovane Nello che suona in stile Jelly Roll Morton, perfino Vivere, la canzone in voga del momento. «Mussolini ce la fece ripetere ventisette volte», ricorda. Poi si avvicina il segretario Alfieri: «Cambiate, fate un valzer, a sua Eccellenza piace il valzer…» E quelli, come se niente fosse fanno un pezzo jazz a tempo di valzer. «Cos’è questo?» si avvicina il Duce con "due occhi così" che fanno paura a Nello. «Un valzer, Eccellenza», balbetta il poveretto. «Bravo, bravo!», disse il Duce. E si mette a ballare pure lui. Il jazz.
Ecco: l’incontro-scontro tra jazz e fascismo fu spesso solo una questione di nomi. Era stato proprio suo figlio Vittorio, che strimpellava il banjo, a importare il jazz (quella "musicazz", quella musicaccia, avrà commentato Donna Rachele in romagnolo) a Villa Torlonia. Lo ricordava Romano, ma lo prova anche la dedica dello studioso ebreo Ezio Levi, che con Giancarlo Testoni pubblica nel 1938 uno dei primi libri sul jazz in Italia: Introduzione alla vera musica di jazz. «Con grata simpatia – scrive sulla copia inviata a Vittorio Mussolini – per avere, tra i primi in Italia, compresa ed apprezzata la vera musica di jazz». Un anno dopo Levi per le leggi razziali è costretto a emigrare negli Stati Uniti.

Di contraddizioni come queste, che mettono a confronto il fascismo, "rivoluzione moderna" del Novecento, come si definiva, con la più rivoluzionaria delle musiche del secolo, il jazz, e dopo il ’38 interrompono anche le amicizie tra appassionati fascisti ed ebrei, è piena la cronaca dell’Italia del Ventennio. Due fenomeni così lontani, il jazz e il fascismo, erano costretti a convivere in un’Italia che li applaudiva entrambi senza capirli davvero. E di questi contrasti Romano, figlio del Duce e jazzista, è stato protagonista e testimone privilegiato.
Oggi che il jazz fosse tabù sotto il fascismo è diventato un luogo comune. Ma, a ben vedere, privo di fondamento reale. C’erano critiche aspre, questo sì, che però cominciarono solo nel ’28. In realtà il costume dell’Italia del Ventennio si rispecchia con le sue ambiguità anche nei rapporti tra jazz e regime. Applaudito, ballato, ascoltato e suonato con entusiasmo per quasi vent’anni dal popolo italiano, tra cui molti erano i fascisti convinti; ma accusato e disprezzato da alcuni giornali zelanti e dall’intellettualità fascista. Che, però, iscrivevano sotto la voce “jazz” perfino il music-hall, la danza charleston, gli spettacoli di varietà nero-americano e la rivista parigina "Revue Nègre" della bellissima e seminuda Josephine Baker, col suo gonnellino di banane.
«Musica ammattita e gambe storte, suoni fischianti, urli di sirene e crepitare di motori", scriveva nel suo libro Jazz band (1929) un Anton Giulio Bragaglia che rifà il verso a Marinetti e sembra parlare d’altro, non di jazz. Insomma, parole in libertà, futurismo puro. Voi direte: però, con quel titolo, si vede che era d’accordo. Macché, solo per insinuarsi, per far finta di capire, in realtà gli serve per denigrare lo "snobismo anglosassone", la "degenerazione" d’un ideale estetico, la mania italiana ed europea per l’esotismo delle "negrerie". Una posizione reazionaria e cripto-razzista. «Come uomini, ci sia rispetto umano fra tutti, ma poi, che debbano venire i negri a insegnarci cosa è arte, o magari cosa si deve fare come divertimento, be’, questa poi…»

E poi c’erano i duri e puri, gli ottusi del Regime. «E’ nefando e ingiurioso per la tradizione, e quindi per la stirpe riportare in soffitta violini, mandolini e chitarre – scrive Carlo Ravasio sul
Popolo d’Italia ("Fascismo e Tradizione") – per dare fiato ai sassofoni e percuotere timpani secondo barbare melodie che vivono soltanto per le efemeridi della moda. E’ stupido, è ridicolo, è antifascista andare in sollucchero per le danze ombelicali di una mulatta e accorrere come babbei ad ogni americanata». E
Critica fascista: «L’America, con il suo jazz sta soffocando le nostre tradizioni» (Adriano Mazzoletti,
Il jazz in Italia, Laterza, questa e altre cit.). Proprio quello che i no-global di destra e sinistra oggi dicono, sparlando dell’America, sulle canzoni, le soap opera della tv, i film, il cibo.
Critiche tardive e inefficaci, però, che nessuno leggeva. Il fenomeno jazz nel ’28 è ormai di massa da un pezzo in Italia. Non dimentichiamo che gli Italiani non erano del tutto nuovi alla musica afro-americana. I primi dischi di “musica sincopata” proto o pre-jazzistica si erano diffusi in Italia durante la prima Guerra Mondiale, al seguito delle truppe americane nostre alleate.
Ma ora, dalla metà degli anni Venti, cominciano ad apparire anche le prime registrazioni di jazz italiano, e vero jazz. La Odeon o Fonotipìa dal 1926 inizia a pubblicare 78 giri di gruppi jazz nostrani, come The Mediolana Jazz Band, milanese, come dice il curioso nome anglo-latino.
«Dove si vuole arrivare?», «La misura è colma»: i duri del regime fascista, tra cui il compositore Mascagni, non ne possono più. Ma anziché far vietare da questori, prefetti e polizia, scrivono articoli sulla terza pagina dei giornali. Il fascismo, insomma, è sulla difensiva, ma in fondo tollerante. Si vede che ha già perso la guerra culturale. Tutto preso dal Potere, ha già dimenticato il passato rivoluzionario e iconoclasta del Futurismo modernista, le provocazioni dell’avanguardia, le cacofonie del nuovo strumento "intona-rumori" di Russolo e Pratella, i brani musicali marinettiani come "Macchina tipografica" e "Battaglia di ritmi". Insomma, anche per come tratta il jazz, si direbbe che il regime stia già ripiegando su posizioni conservatrici e piccolo-borghesi, tipiche del perbenismo della vecchia provincia italiana. Delle due componenti originarie ha ormai scelto quella minore e più retriva, il nazionalismo, non il socialismo.
Il fascismo, quindi, non vieta la nuova musica afro-americana, ma ne sparla. Il jazz? «Niente musica e tutto ritmo», scrive il Popolo d’Italia vellicando la sottocultura della provincia italiana. Ma, per quanto aspra, l’opposizione dei polemisti di giornale alla musica negro-americana si mantiene entro i limiti del dibattito. Bisogna riconoscere che mai viene usato il potere per vietarlo, almeno fino alle leggi razziali del 1938 (che discriminano autori e musicisti ebrei) e alla dichiarazione di guerra agli Stati Uniti nel 1941 (che vietano titoli, nomi e musiche americane). Decreti che, però, furono facilmente aggirati, come vedremo.

Ecco perché il jazz, di fatto, ebbe via libera in Italia, fino al boom, sotto il fascismo, compiendo un’ascesa del tutto parallela a quella del Regime. Paradossi della Storia e della cultura. L’"Età del jazz", musica negra e americana per eccellenza, in piena Italia fascista e nazional-popolare. Soprattutto dal 1924 al 1929, dopodiché il suo filone più commerciale si andò annacquando in forme popolari, di massa.
Da Torino a Milano e a Venezia, da Bologna a Roma (il sud era più emarginato, ma perfino la Gazzetta del Mezzogiorno, di Bari, pubblicò un articolo, critico, sulla "moda del jazz") sembrava di vivere in un romanzo di Scott Fitzgerald, con la gente che impazziva per sassofoni e batterie, trombe e contrabbassi, a far da contrasto con le melodie ritmate dei cantanti. E c’erano impresari furbi che spacciavano un po’ tutto per "jazz-band", come del resto accadeva negli Stati Uniti e in Inghilterra. Un vero boom, anche in Italia, che durò per tutti gli anni Venti e Trenta. Non c’era bisogno di affrontare un costoso viaggio per mare di 5 o 6 giorni sui transatlantici veloci “Conte di Biancamano” o “Rex”, per poter ascoltare la musica di Bix e di Louis negli States.
Mandolino, addio. Agli inizi solo i Reali Carabinieri della banda della Benemerita erano capaci di suonare bene il sassofono, anche se non sapevano fare linee melodiche o tantomeno assoli, ma solo accompagnamento. Poi, a poco a poco, copiando dai dischi importati e dai musicisti americani in tournée in Italia, vennero fuori centinaia di strumentisti bravi. Ed erano richiestissimi perfino quelli in grado di suonare gli strumenti più eccentrici. Come Pietro Sordi, padre del futuro attore Alberto, suonatore di basso tuba.
Il livello tecnico e musicale dei primi musicisti italiani che suonavano vero jazz era dignitoso, anche se la loro fantasia solistica, forse per difetto di modelli musicali, non era paragonabile a quella dei jazzmen d’oltre-Atlantico. Non si sa se per cortesia anglosassone, il violinista Eddie South nel ’31, di ritorno da una tournée in Italia, dichiara al Chicago Defender: «Gli italiani suonano altrettanto bene degli americani». Nientemeno. Il sassofonista Franco Mojoli – raccontò il critico Roberto Nicolosi – impallidì quando ascoltò il clarinetto della big band del nero Andy Kirk, John Harrington: «Ma questo sono io…». Aveva scoperto il jazz con l’orchestra del varietà "Black Poeple", diretta dal grande creolo Sidney Bechet, in tournée a Milano nel 1927.
Altro che "isolati" e "fuori dall’Occidente", gli scambi con l’America sono frequenti. Il jazz è la prima musica "globale", e l’Italia lo riceve, accetta, interpreta e ripropone proprio sotto il fascismo nazionalista. Gli italiani accorrono alle grandi tournées delle orchestre Usa, talvolta inserite in grandi spettacoli di "rivista negra", con decine di cantanti e ballerini, e scene di piantagioni di cotone, battelli sul Mississippi, strade di New York. "Black People", per esempio, tocca Venezia, Bologna, Firenze, Milano e Roma. Quando Louis Armstrong nel ’35 (15-16 gennaio) suona a Torino, al Teatro Chiarella, La Stampa riferisce di una coda lunga tre isolati e di centinaia di automobili parcheggiate. Grande successo e incasso favoloso. Armstrong stesso invia dalla nave, sulla via del ritorno negli States, una curiosa lettera di ringraziamento all’organizzatore torinese Alfredo Antonino. Gli impresari di Milano, che avevano detto no, si mangiano le mani dalla rabbia. Ma i giornali non riportarono recensioni, ha ricordato M. Maletto sul Corriere della Sera. Il critico liberale Massimo Mila, presente in sala (poi esponente di punta di Giustizia e Libertà), ne poté scrivere, e con entusiasmo, solo a Liberazione avvenuta.
E insieme alle orchestre bianche "commerciali" da ballo, alla Jack Hylton, il pubblico arriva a scoprire proprio il vero jazz dei "negri", definito "hot", caldo, dai primi esperti, come Nizza su La Stampa (futuro co-autore con Morbelli, alla radio EIAR, dei fortunatissimi Tre moschettieri). In quegli anni i negri sono di moda in tutt’Europa. Più di oggi. Sarà stato per l’esotismo, per la simpatia popolare per gli etiopici ancora ridotti in schiavitù, di cui profitterà il Fascismo per legittimare l’invasione colonialista (Faccetta nera, di Micheli e Ruccione è del ‘35, e non nasce affatto come canzone fascista, anzi, all’inizio piaceva poco al Regime quella fraternizzazione), fatto sta che proprio sotto il fascismo trionfò per paradosso la tesi del critico bianco francese Hugues Panassié, poi accusato di razzismo al contrario, che aveva messo in testa agli europei che il jazz fosse solo nero.

Verso il ‘35, l’italiana Odeon edita per la sua collana Swing Series una serie di dischi specializzata nel puro jazz, diremmo oggi, divulgando alcune importanti registrazioni di jazzisti americani. La Cetra, a partire dal 1933, ristampa per l’Italia molti brani jazz editi a suo tempo dalla Parlophon.
D’altra parte, perché meravigliarsi, noi Italiani potevamo considerarci per un colpo di fortuna quasi dei “fondatori” del jazz. Gli zelanti giornalisti del Popolo d’Italia non lo sapevano, ma il primo disco jazz della storia era stato inciso il 17 febbraio 1917 da un "paisà", il cornettista Nick La Rocca, italo-americano di New Orleans, figlio d’un siciliano di Salaparuta, con la sua Original Dixieland Jass (così si scriveva all’inizio) Band. Otto anni prima del grande Armstrong, certo più bravo, ma anche meno intrallazzone, e soprattutto negro. A La Rocca oggi i siciliani hanno eretto un busto, hanno dedicato sale di teatro e scritto anche una monografia, a cura di Claudio Lo Cascio ("Nick La Rocca: una storia nel jazz", ed. Novecento).
Ebbene, pochi sanno che in Italia questo disco della ODJB si stampò appena tre anni dopo, nel 1920, dalla Grammofono, ed. it. della His Master Voice o Voce del Padrone. Neanche oggi, in alcuni casi, la musica degli Stati Uniti arriva in Italia con tale “velocità”.
E prima c’erano stati il leggendario Jack "Papa" Laine (George Vitale), leader di varie orchestre poi mitizzato come capostipite del bianco stile Dixieland, e il mitico clarinettista Leon Roppolo (o Rappolo), che tutti i jazz fans del mondo ritengono americani anglosassoni, se non addirittura negri! Il basso-tuba Joe Alexander (Giuseppe Alessandra), nato in Italia, per nostalgia suonava a New York in divisa del Regio Esercito italiano. Ebbene, questi quattro italiani, i primi tre famosissimi, il secondo sconosciuto, sono tra "i primi musicisti jazz" della storia.
E non parliamo degli anni successivi. Negli Usa centinaia di altri grandi jazzisti di origine italiana, solisti o musicisti di fila, erano attivi negli anni del Ventennio italiano. Tra questi il violinista Joe Venuti, il chitarrista Eddie Lang (Salvatore Massaro), il sax basso Adrian Rollini, il pianista Frank Signorelli, i sassofonisti Flip Phillips (Joseph Filippelli) e Charlie Ventura. I federali fascisti non lo sapevano, ma il jazz era anche un po’ cosa nostra.
In pieno regime fascista, ad ogni modo, l’Italia esporta musica lirica e importa musica jazz. Il fisarmonicista Gorni Kramer (ma il cognome era Gorni), senza dubbio «il più originale jazzista italiano di quegli anni” (Mazzoletti), ha ricordato che anche nel suo Mantovano gli emigrati italiani che tornavano dall’America al paesello portavano con sé qualche disco di ebanite delle grandi orchestre americane di jazz. E non solo Paul Whiteman e Casa Loma, ma anche i Cotton Pickers, Chick Webb, e chissà anche i solisti di tromba Bix Beiderbecke e Red Nichols, e poi la big band del clarinettista Benny Goodman. Insomma, tutta la storia del jazz di New Orleans, Chicago e New York, il dixieland e lo swing, sono rivissuti in diretta in Italia. Una valanga inarrestabile. Almeno, fino alla sterzata drammatica delle leggi razziali. Dopotutto il Ventennio ha origine nel 1922, ma i divieti per il jazz arrivano solo nel ‘41.
La moda, il consumismo d’allora, il mercato, vuole che ogni cosa sia "jazz". La parola "vende" sul piano del marketing più della stessa musica. Nel 1925 un film americano con l’attrice Gloria Swanson, dall’innocuo titolo "Prodigal Daughter", per ragioni di botteghino è intitolato dal distributore italiano "Jazz-band". Grande successo. E’ seguito in cartellone da un altro film americano dal titolo "Jazzmania", con la Murray. Lo scrittore alla moda di quegli anni, Lucio d’Ambra, ovviamente, sforna subito il suo romanzo dal titolo ad hoc “La repubblica del jazz-band” (1929). Ecco, questi episodi danno un po’ l’idea che la "jazz craze", la pazzia per il jazz così bene ritratta in America dallo scrittore Francis Scott Fitzgerald, esempio di quell’infatuazione collettiva tipica delle società di massa del Novecento, di cui il fascismo conosceva bene i meccanismi, dall’America era passata all’Europa e all’Italia.
Il mercato, per la prima volta, supera ogni ideologia. Neanche il fascismo può farci nulla. E, a parte le centinaia di complessini, l’Italia fascista conta decine di big band, grandi orchestre di “jazz” annacquato (noi diremmo oggi: “musica leggera ritmica para-jazzistica”) specializzate nelle grande musica da ballo e nei veglioni. Un solo esempio, raccontato dal Mazzoletti, è il Gran Veglione di mezza Quaresima, un’usanza oggi sparita, che vede a Torino nel ‘31 la sfida "Super Jazz" con il meglio degli orchestrali del Jazz sinfonico Chiappo, diretti da due direttori diversi in competizione tra loro: una vera "battle" all’americana.

Ma ormai l’Italia fascista del jazz ha anche molti bravi solisti. Dopo il 1930 vanno maturando tutta una folta schiera di strumentisti di valore, dal sassofonista Piero Rizza (la sua Louisiana Band nel ’29 aveva inciso i primi otto brani di vero jazz italiano con la Fonotecnica) all’eccentrico pianista Romeo Alvaro, che quando aveva freddo suonava con i guanti. Senza contare i fisarmonicisti Kramer e Beltrami, i trombettisti Marzaroli ("il Bix italiano") e Impallomeni, e i vari Ceragioli, i Di Ceglie, i Trovajoli. Che lavoravano normalmente, davano concerti e guadagnavano. Tutto alla luce del sole. E con tanto di gerarchi fascisti ad applaudire tra il pubblico. L’EIAR si adegua a furor di popolo. Il 3 novembre 1936 alle 17,20 va in onda una trasmissione radio con l'Orchestra di Rizza che propone tutti brani di autori stranieri e molto jazz. A gennaio del 1937 iniziano le trasmissioni dell'orchestra jazz Ramponi. Il 6 aprile furono di scena Kramer ed i suoi solisti. Il quartetto jazz dell'Eiar suona regolarmente tutte le sere alle 20,40. L’orchestra del jazzista Sesto Carlini nel ’38 e ‘39 è ingaggiata anche in Olanda, Londra e New York. Ancora in pieno ’39 in Italia si esibisce un’orchestra internazionale con jazzisti anglosassoni e italiani. Mussolini vuole ancora dimostrare che è Hitler a volere la guerra, ma l’Italia no, è un paese pacifico, pluralista e cosmopolita. Poi, invece…
Dopo il ‘41 quasi sparisce la parola "jazz" dalle locandine. La musica però resta, anche se la censura sulla parola “jazz” è destinata a durare. Ma non scandalizziamoci troppo. Perché in piena democrazia, fino agli anni ‘70 nella RAI democristiana, anzi addirittura fino ai nostri giorni, è stato ed è tuttora difficile, se non impossibile, far passare in radio e televisione la parola "jazz", non solo nei programmi ma ancor più nei titoli. Spesso i funzionari – e sono quasi tutti di sinistra – suggeriscono all’autore umilianti eufemismi, il migliore dei quali è "Quel certo ritmo". Come nel fascismo. Anzi, peggio, perché il fascismo si comportò così solo in tempo di guerra.
E fu così, ma solo allora, che il gruppo dei Three Nigger Boy’s (Kramer Gorni, Enzo Ceragioli e Cosimo Di Ceglie) diventano prima “I Tre Negri” e poi “Tre Italiani in America”, e cambiano titolo a Sonny Boy (“Bambino mio adorato”). Molti altri titoli strani, che potevano dare nell’occhio, sono italianizzati, come Jeepers Creepers che diventa un più rassicurante "Ah, Giulietta". Altri titoli sono velocemente e malamente tradotti in italiano, forse con un pessimo vocabolario sotto gli occhi, da qualche burocrate SIAE, come St. Louis Blues ("Le tristezze di San Luigi"). L’orchestra “Maestri del Ritmo” (Pittana alla tromba, Mojoli e Cottiglieri ai saxes e Ceragioli al piano) traduce sui bollettini dei diritti d’autore Moonglow in "Mia pallida luna" e Honeysuckle Rose addirittura in "Pepe sulle rose".

Altro non ci fu contro il jazz. Del resto, anche nella musica leggera, il capo della censura, Criscuolo, vedeva pericoli e allusioni ovunque. Come in “
Crapa pelada” (1936), di Kramer, che il popolino credeva alludesse al lucido cranio del Duce, o in "
Maramao, perché sei morto?" (1939), che Panzeri dovette provare di aver composto prima della morte di Costanzo Ciano; mentre si tratta di un'antica filastrocca popolare che già nel 1831 era costata l’arresto da parte della polizia pontificia dell’incauto nottambulo che l’aveva canticchiata dopo i funerali del Papa, come si legge in un sonetto romanesco (G.G. Belli,
Er canto provìbbito, 11 febbraio 1833). La gustosa vicenda, che smentisce alcuni luoghi comuni e coinvolge curiosamente gatti, censura pontificia e censura fascista, è raccontata in questo
articolo.
Aneddoti e luoghi comuni, però, che non ci aiutano a capire. Non bisogna confondere l'anti-americanismo di guerra e la censura, che ci furono ma molto tardi, con la precedente condanna “culturale” del jazz come stile musicale, che in pratica non aveva portato mai a nessun divieto. Perché la dittatura, almeno in queste cose, conservò un briciolo di buonsenso, nonostante i proclami, oppure perché era la solita Italia dei due pesi e due misure, «Qui lo faccio e qui lo nego», «In pubblico è una cosa, ma in casa mia un’altra». Anche nei confronti del jazz, il fascismo come fenomeno di psicologia sociale fu profondamente italiano e individualistico.
Ma la musica, per fortuna, è sempre la stessa, Duce o non Duce. Perfino in tempo di guerra, con un po’ di camuffamenti e addolcimenti, gli italiani – fascisti compresi – continuano a ballare, ascoltare e suonare sia il vero jazz, sia la tanta musica leggera para-jazzistica che andava di moda. E come grida manzoniane, le rampogne di giornali che nessuno leggeva e i decreti d’emergenza nulla possono contro un intero popolo, già ultra-melodico, che dopo secoli di astinenza dal ritmo imposta dalla lirica all’italiana, riscopre con eccitazione il piacere atavico del ritmo, che con buona pace del Popolo d’Italia, è alla base della musica. Lo aveva riconosciuto già nel ‘22 il compositore classico Casella, dopo un viaggio negli Stati Uniti.
In pubblico, nei programmi di guerra dell'Eiar, la radio di regime, nei comizi ufficiali, davanti ai grossi microfoni a carbone Geloso, si predicava "italianità", anche nella musica. Era il mito contadino "nazional-popolare". Tollerato il Belcanto borghese, erano favorite le corali vagamente guerresche, i canti rurali, i balli tradizionali, o le canzoni in cui, in mancanza d’una musica fascista, ci fossero almeno le parole e le circostanze ("Giovinezza", "Faccetta nera") a ricordare il regime.
Ma in privato, era tutta un’altra musica. Anche i federali fascisti «tenevano famiglia». Nel buio dei tabarin affittati, nelle arene dei ritrovi danzanti esclusivi, o sulle terrazze a mare d’estate, e soprattutto nei veglioni o semplicemente nel segreto del salotto di casa davanti alla radio Allocchio Bacchini o Balilla o, per gli alto-borghesi, all’imponente radio-grammofono Marelli di legno lucido impiallacciato a noce (con la valvola verdina dell’ "occhio magico" per la sintonia), si continuava ad ascoltare e ballare la cantante creola, la musica quasi negra, il travolgente ritmo simil-americano, insomma il “jazz”. E mentre laggiù si cominciava a sparare, alla radio come se niente fosse impazzava il buon surrogato italico, il brillantissimo swing vocale del formidabile Trio Lescano (le sorelle olandesi Sandra, Giuditta e Caterinetta Leschan), lo “scat” addolcito di Natalino Otto, un compromesso tra il melodismo nostrano e lo swing, diciamo un Cab Calloway alle vongole ("Ba-ba-baciami piccina, sulla bo-bo-bocca piccolina…"), la più tradizionale orchestra ritmica di Pippo Barzizza.
E, a parte i famosi, c’erano centinaia di complessini fantastici di entusiasmante musica ritmica para-jazzistica. Popolare, popolarissima. Le contrastanti linee melodiche della sezione dei fiati, sorrette dalla ritmica, dialogavano tra loro in modo virtuosistico, con incastri precisi che lasciavano a bocca aperta chi era abituato alla monodia della canzone all'italiana che imitava ancora Caruso o Beniamino Gigli. E invece, in quei brevi ghirigori, in quei ruvidi assoli di sassofono presi a prestito dal jazz, in quegli intrecci strumentali che come per miracolo si ricomponevano proprio alla fine, giovani e vecchi riscoprivano il fascino della polifonia popolare, della amatissima banda di paese. Insomma, vocalizzo italiano (voce, tromba o violino), un po’ di collettivo strumentale, molti riff ripetuti, e tanto ritmo americano: il massimo per la buona musica leggera d’allora.
Ma era il jazz autentico che piaceva alla classe dirigente dell’Italia fascista e agli appassionati. Se no, in seguito, non avremmo trovato così tanti dischi a 78 giri nei mercatini di anticaglie. E i jazzisti lavoravano sempre. Ma con qualche piccola "precauzione" dopo le leggi razziali. "Mi cerchi un bravo pianista, ma non mi proponga ebrei", raccomandò nel ’39 un direttore d’orchestra al jazzista Bios Vercelloni per un ingaggio a Berlino. Molti furono i jazzisti italiani che suonarono in Germania, attratti dalle paghe alte, tra cui Tullio Mobiglia – gli fu affidato anche il ruolo di "Spezial Jazzmusiker" per un film di propaganda – Astore Pittana, Alfredo Marzaroli, Baldo Maestri, Mario Balbo e Alfio Grasso. Quest’ultimo influenzò musicisti di jazz tedeschi, tra cui Helmuth Zacharias e poi quella che allora era considerata una cantante jazz, Caterina Valente. Va da sé che i titoli dei brani americani suonati da Mobiglia al Patria Bar di Berlino ora erano tedeschi: "Sei frohlich mein junge" invece di Take it Easy, Boy.
E perciò non meraviglia che in piena guerra, nel ‘42-43, anche i jazzisti sono arruolati in quella che è la prima "guerra psicologica" della storia. Come contro-informazione, alcune radio naziste in Germania e nel Nord Italia fingono di essere radio inglesi clandestine. Dunque, jazz a più non posso, e tra un brano e l’altro di jazz parecchie notizie false e depistanti.
E così «ci fu il paradosso di generali della Wermacht che fondarono nuove orchestre jazz, anche italiane», ricorda Luca Cerchiari, docente di Civiltà musicale afro-americana all’Università di Padova, che ha scritto un saggio sui rapporti tra jazz e fascismo. E’ uno scherzo del destino: ora anche alla Repubblica di Salò i jazzisti tornano utili. A tutto jazz, quindi, le stazioni radio fascistissime del Nord Italia ("Radio Balilla"), sotto la direzione tedesca. «Facevamo finta di essere una radio americana», racconta Giampiero Boneschi, che vi lavorava. E con altro jazz, di segno contrario, replicavano al Sud da radio Bari, Napoli e Roma. Democrazia contro nazismo, jazz contro jazz.
Una guerra anche di note, un po’ alla Ridolini. Il militare Trovajoli, pianista, anziché essere fucilato per diserzione, è sbattuto per punizione ad Atene. Tutta colpa d’un organizzatore di concerti jazz, ex aviatore dei "sorci verdi" e amico di Vittorio Mussolini e Ciano, che lo aveva ingaggiato a Berlino dimenticando di avvertire le autorità militari in Italia. Ma a Radio Atene il generale Geloso incarica Trovajoli di metter sù per lo svago delle truppe italiane un’orchestrina jazz. Grande successo tra la gioventù bene della città greca, che dimentica il sirtaki e affolla gli studi.
Insomma, anche i poco bellicosi jazzisti, a modo loro, con batterie, tromboni e sassofoni, fecero la guerra. All’italiana, però: cioè da una parte e dall’altra. E quando finalmente Renato Germonio dell’Hot Club di Torino incide nel ‘45 Body and Soul e Sweet Georgia Brown, be’, è segno che sono arrivati gli americani, quelli veri, e la guerra – anche la "guerra del jazz" – è finita davvero. Fra poco arriverà la Repubblica.
NICO VALERIO*
DIRITTI RISERVATI*
IMMAGINI. 1. L’orchestra (“jazz band”) di Tullio Mobiglia negli anni 30. 2. Il giovanissimo Romano Mussolini al pianoforte di villa Torlonia, con accanto la sorella. Come si vede, sta leggendo lo spartito: perciò è una leggenda, alimentata da lui stesso con un certo snobismo (come aveva fatto già Louis Armstrong per assecondare l’ingenuità dei suoi fans), che non conoscesse la scrittura musicale, che del resto perfino il padre Benito, dilettante di violino, conosceva. Anzi, mi raccontò una sera Romano che, agli inizi, sorpreso dal padre a strimpellare al piano jazz, si sentì quasi sollevato quando il Duce lo rimproverò, sì, ma solo perché non sapeva ancora leggere bene la musica! 3. Il libro “Jazz band” dell’intellettuale fascista Anton Giulio Bragaglia, che di jazz non capiva assolutamente nulla. 4. “Introduzione alla vera musica di jazz” (ed. Corbaccio), libro pubblicato nel 1938 da Ezio Levi e Giancarlo Testoni (che dopo la Liberazione con Arrigo Polillo fonderà “Musica Jazz”). 5. La copertina di uno dei tanti pregevoli cd sul jazz italiano degli anni 30 e 40 (con la consulenza preziosa di Adriano Mazzoletti) della casa Riviera Jazz Records. Questo presenta brani rarissimi degli anni 40, con Giampiero Boneschi, Mojoli, Volontè e altri. 6. Il sax tenore Tullio Mobiglia, che suonò anche in Germania (cd della Riviera Jazz Records). 7. Il grande Kramer (nome) Gorni (cognome), poi noto fisarmonicista di successo come Gorni Kramer, in un pregevole cd antologico sul jazz italiano degli anni 30 (cd della Riviera Jazz Records). I jazzisti italiani avevano anche molto humour: un complessino si chiamava I tre negri. 8. Un disco jazz a 78 giri col titolo del brano di Lionel Hampton mal tradotto.
DISCHI. Per saperne di più, sono indispensabili gli interessantissimi dischi cd della collana “Jazz in Italy” della Riviera Jazz Records, benemerita piccola casa discografica italiana che sta diffondendo il grande patrimonio culturale della musica ritmico-leggera italiana degli anni ‘20, ‘30 e ‘40, rivelando incisioni davvero uniche, musicisti sconosciuti e incredibili. Dischi che i collezionisti di tutto il mondo si contendono. Tre copertine di questi preziosi cd sono riprodotte come immagini nel presente articolo. Insomma, un’opera davvero meritoria, di cui tutti gli appassionati, sia di jazz, sia di cultura italiana, dovrebbero ringraziare il produttore e direttore artistico, lo storico e collezionista Adriano Mazzoletti. I dischi si possono acquistare nei più importanti negozi specializzati, o meglio ancora attraverso il sito internet. Alla Riviera Jazz Record e alla sua animatrice Anna Maria Pivato va il nostro plauso sentito. Complimenti. Per questa iniziativa, puramente culturale, il nostro sito fa eccezione alla regola severissima di non fare pubblicità. Che in questo caso, vi assicuro, è doverosa.
* NOTA. Diritti riservati (v. condizioni di Creative Commons sul colonnino). Articolo pubblicato, con qualche riduzione effettuata dallo stesso autore, dal settimanale di cultura Il Domenicale. Veramente meritava di più, e infatti era stato proposto anche al Corriere della Sera, facendolo leggere in anteprima al grande giornalista Giovannino Russo (“Bellissimo, complimenti, un vero scoop culturale; ma togliti dalla testa che articoli così lunghi si possano pubblicare oggi dai quotidiani, anche in terza pagina. Non è più come ai miei tempi…”). Eppure, lunghe “articolesse”, sempre uguali, o gruppi di articoli (e non è la stessa cosa?) sono pubblicati su calcio, politica, l’ultimo libro dello scrittore alla moda, opera lirica, pettegolezzi tv, festival della canzonetta a Sanremo ecc. Così lo inviai alla Repubblica dove, nonostante che sia stato loro collaboratore anni addietro, mi destinarono prima 60, poi 40, poi 20 righe sul supplemento illustrato del giovedì o del sabato. Loro che ne sprecano centinaia su rock, vacanze in ville snob nel Chianti, mostra del cinema di Venezia, Sanremo, l’ultimo romanzo che non vale niente o l’ultima borsetta alla moda. Rifiutai. Si offrì di pubblicarlo anche Il Tempo, ma con ampi tagli. Quelli del Giornale e del Foglio, se ricordo bene, invece, neanche risposero. Come è peggiorato il giornalismo in Italia da quando l’ho lasciato! E poi si lamentano se nessuno legge più i giornali! Perché non provano a cambiare giornalisti e direttori? Non se ne accorgono, ma pubblicano sempre gli stessi articoli. Via via sempre più brevi! E scritti sempre peggio…
AGGIORNATO IL 22 MARZO 2015
Etichette: costume, cultura, dittatura, jazz, musica, politica, satira, storia
 Nonostante le critiche, più che i divieti, dei giornali del Regime, la musica dei “negri” e degli americani ebbe grande successo in Italia nell’infausto Ventennio. Tutti ascoltavano e ballavano il “jazz”, vero o annacquato che fosse. Anzi, tanto di moda era quel nome o quel ritmo che ogni musica per avere successo doveva essere “jazz-band”. E i gerarchi? E Mussolini? Bastava dire che si trattava di un valzer o una mazurka. Così, con qualche trucco, lo si suonava e ascoltava perfino dopo le leggi razziali e anti-americane, durante la guerra e nell’Italia divisa. E ci furono addirittura generali della Wermacht e fascisti che organizzarono orchestre jazz. E anche i jazzisti, alla radio (radio Bari contro radio Salò), a modo loro “fecero la guerra”…
Nonostante le critiche, più che i divieti, dei giornali del Regime, la musica dei “negri” e degli americani ebbe grande successo in Italia nell’infausto Ventennio. Tutti ascoltavano e ballavano il “jazz”, vero o annacquato che fosse. Anzi, tanto di moda era quel nome o quel ritmo che ogni musica per avere successo doveva essere “jazz-band”. E i gerarchi? E Mussolini? Bastava dire che si trattava di un valzer o una mazurka. Così, con qualche trucco, lo si suonava e ascoltava perfino dopo le leggi razziali e anti-americane, durante la guerra e nell’Italia divisa. E ci furono addirittura generali della Wermacht e fascisti che organizzarono orchestre jazz. E anche i jazzisti, alla radio (radio Bari contro radio Salò), a modo loro “fecero la guerra”… Villa Torlonia (“Villa Mussolini” per i romani d’allora) riportata al suo antico splendore sembra per una curiosa vendetta della Storia una piccola Casa Bianca, con quell'austero frontone, le colonne neoclassiche e l’ampia scalinata tra i vialetti di ghiaia e il verde. Pare impossibile, scomparso Romano, figlio del Duce e pianista di jazz che vi abitò da bambino, che in questa villa neoclassica dal sapore americano siano potute risuonare nello stesso tempo la voce del capo del fascismo e le note del jazz. Anzi, visto lo stile, forse era proprio il papà ad essere fuori posto, non il figlio.
Villa Torlonia (“Villa Mussolini” per i romani d’allora) riportata al suo antico splendore sembra per una curiosa vendetta della Storia una piccola Casa Bianca, con quell'austero frontone, le colonne neoclassiche e l’ampia scalinata tra i vialetti di ghiaia e il verde. Pare impossibile, scomparso Romano, figlio del Duce e pianista di jazz che vi abitò da bambino, che in questa villa neoclassica dal sapore americano siano potute risuonare nello stesso tempo la voce del capo del fascismo e le note del jazz. Anzi, visto lo stile, forse era proprio il papà ad essere fuori posto, non il figlio.  Ma il jazz non era vietato dal fascismo? Sì, anzi, no. Per capire quanto il regime, nonostante i toni burberi, fosse di manica larga con la musica di derivazione afroamericana, che non riuscì mai ad estirpare, ecco un eloquente aneddoto raccontato da Nello Di Geronimo, un trombonista jazz così bravo che per anni – racconta lo storico Mazzoletti – i critici credettero che in Stompin’ at The Savoy, del 1938, a suonare non fosse lui, ma "qualche musicista straniero".
Ma il jazz non era vietato dal fascismo? Sì, anzi, no. Per capire quanto il regime, nonostante i toni burberi, fosse di manica larga con la musica di derivazione afroamericana, che non riuscì mai ad estirpare, ecco un eloquente aneddoto raccontato da Nello Di Geronimo, un trombonista jazz così bravo che per anni – racconta lo storico Mazzoletti – i critici credettero che in Stompin’ at The Savoy, del 1938, a suonare non fosse lui, ma "qualche musicista straniero".  Di contraddizioni come queste, che mettono a confronto il fascismo, "rivoluzione moderna" del Novecento, come si definiva, con la più rivoluzionaria delle musiche del secolo, il jazz, e dopo il ’38 interrompono anche le amicizie tra appassionati fascisti ed ebrei, è piena la cronaca dell’Italia del Ventennio. Due fenomeni così lontani, il jazz e il fascismo, erano costretti a convivere in un’Italia che li applaudiva entrambi senza capirli davvero. E di questi contrasti Romano, figlio del Duce e jazzista, è stato protagonista e testimone privilegiato.
Di contraddizioni come queste, che mettono a confronto il fascismo, "rivoluzione moderna" del Novecento, come si definiva, con la più rivoluzionaria delle musiche del secolo, il jazz, e dopo il ’38 interrompono anche le amicizie tra appassionati fascisti ed ebrei, è piena la cronaca dell’Italia del Ventennio. Due fenomeni così lontani, il jazz e il fascismo, erano costretti a convivere in un’Italia che li applaudiva entrambi senza capirli davvero. E di questi contrasti Romano, figlio del Duce e jazzista, è stato protagonista e testimone privilegiato.  E poi c’erano i duri e puri, gli ottusi del Regime. «E’ nefando e ingiurioso per la tradizione, e quindi per la stirpe riportare in soffitta violini, mandolini e chitarre – scrive Carlo Ravasio sul Popolo d’Italia ("Fascismo e Tradizione") – per dare fiato ai sassofoni e percuotere timpani secondo barbare melodie che vivono soltanto per le efemeridi della moda. E’ stupido, è ridicolo, è antifascista andare in sollucchero per le danze ombelicali di una mulatta e accorrere come babbei ad ogni americanata». E Critica fascista: «L’America, con il suo jazz sta soffocando le nostre tradizioni» (Adriano Mazzoletti, Il jazz in Italia, Laterza, questa e altre cit.). Proprio quello che i no-global di destra e sinistra oggi dicono, sparlando dell’America, sulle canzoni, le soap opera della tv, i film, il cibo.
E poi c’erano i duri e puri, gli ottusi del Regime. «E’ nefando e ingiurioso per la tradizione, e quindi per la stirpe riportare in soffitta violini, mandolini e chitarre – scrive Carlo Ravasio sul Popolo d’Italia ("Fascismo e Tradizione") – per dare fiato ai sassofoni e percuotere timpani secondo barbare melodie che vivono soltanto per le efemeridi della moda. E’ stupido, è ridicolo, è antifascista andare in sollucchero per le danze ombelicali di una mulatta e accorrere come babbei ad ogni americanata». E Critica fascista: «L’America, con il suo jazz sta soffocando le nostre tradizioni» (Adriano Mazzoletti, Il jazz in Italia, Laterza, questa e altre cit.). Proprio quello che i no-global di destra e sinistra oggi dicono, sparlando dell’America, sulle canzoni, le soap opera della tv, i film, il cibo.  Ecco perché il jazz, di fatto, ebbe via libera in Italia, fino al boom, sotto il fascismo, compiendo un’ascesa del tutto parallela a quella del Regime. Paradossi della Storia e della cultura. L’"Età del jazz", musica negra e americana per eccellenza, in piena Italia fascista e nazional-popolare. Soprattutto dal 1924 al 1929, dopodiché il suo filone più commerciale si andò annacquando in forme popolari, di massa.
Ecco perché il jazz, di fatto, ebbe via libera in Italia, fino al boom, sotto il fascismo, compiendo un’ascesa del tutto parallela a quella del Regime. Paradossi della Storia e della cultura. L’"Età del jazz", musica negra e americana per eccellenza, in piena Italia fascista e nazional-popolare. Soprattutto dal 1924 al 1929, dopodiché il suo filone più commerciale si andò annacquando in forme popolari, di massa.  Verso il ‘35, l’italiana Odeon edita per la sua collana Swing Series una serie di dischi specializzata nel puro jazz, diremmo oggi, divulgando alcune importanti registrazioni di jazzisti americani. La Cetra, a partire dal 1933, ristampa per l’Italia molti brani jazz editi a suo tempo dalla Parlophon.
Verso il ‘35, l’italiana Odeon edita per la sua collana Swing Series una serie di dischi specializzata nel puro jazz, diremmo oggi, divulgando alcune importanti registrazioni di jazzisti americani. La Cetra, a partire dal 1933, ristampa per l’Italia molti brani jazz editi a suo tempo dalla Parlophon. Ma ormai l’Italia fascista del jazz ha anche molti bravi solisti. Dopo il 1930 vanno maturando tutta una folta schiera di strumentisti di valore, dal sassofonista Piero Rizza (la sua Louisiana Band nel ’29 aveva inciso i primi otto brani di vero jazz italiano con la Fonotecnica) all’eccentrico pianista Romeo Alvaro, che quando aveva freddo suonava con i guanti. Senza contare i fisarmonicisti Kramer e Beltrami, i trombettisti Marzaroli ("il Bix italiano") e Impallomeni, e i vari Ceragioli, i Di Ceglie, i Trovajoli. Che lavoravano normalmente, davano concerti e guadagnavano. Tutto alla luce del sole. E con tanto di gerarchi fascisti ad applaudire tra il pubblico. L’EIAR si adegua a furor di popolo. Il 3 novembre 1936 alle 17,20 va in onda una trasmissione radio con l'Orchestra di Rizza che propone tutti brani di autori stranieri e molto jazz. A gennaio del 1937 iniziano le trasmissioni dell'orchestra jazz Ramponi. Il 6 aprile furono di scena Kramer ed i suoi solisti. Il quartetto jazz dell'Eiar suona regolarmente tutte le sere alle 20,40. L’orchestra del jazzista Sesto Carlini nel ’38 e ‘39 è ingaggiata anche in Olanda, Londra e New York. Ancora in pieno ’39 in Italia si esibisce un’orchestra internazionale con jazzisti anglosassoni e italiani. Mussolini vuole ancora dimostrare che è Hitler a volere la guerra, ma l’Italia no, è un paese pacifico, pluralista e cosmopolita. Poi, invece…
Ma ormai l’Italia fascista del jazz ha anche molti bravi solisti. Dopo il 1930 vanno maturando tutta una folta schiera di strumentisti di valore, dal sassofonista Piero Rizza (la sua Louisiana Band nel ’29 aveva inciso i primi otto brani di vero jazz italiano con la Fonotecnica) all’eccentrico pianista Romeo Alvaro, che quando aveva freddo suonava con i guanti. Senza contare i fisarmonicisti Kramer e Beltrami, i trombettisti Marzaroli ("il Bix italiano") e Impallomeni, e i vari Ceragioli, i Di Ceglie, i Trovajoli. Che lavoravano normalmente, davano concerti e guadagnavano. Tutto alla luce del sole. E con tanto di gerarchi fascisti ad applaudire tra il pubblico. L’EIAR si adegua a furor di popolo. Il 3 novembre 1936 alle 17,20 va in onda una trasmissione radio con l'Orchestra di Rizza che propone tutti brani di autori stranieri e molto jazz. A gennaio del 1937 iniziano le trasmissioni dell'orchestra jazz Ramponi. Il 6 aprile furono di scena Kramer ed i suoi solisti. Il quartetto jazz dell'Eiar suona regolarmente tutte le sere alle 20,40. L’orchestra del jazzista Sesto Carlini nel ’38 e ‘39 è ingaggiata anche in Olanda, Londra e New York. Ancora in pieno ’39 in Italia si esibisce un’orchestra internazionale con jazzisti anglosassoni e italiani. Mussolini vuole ancora dimostrare che è Hitler a volere la guerra, ma l’Italia no, è un paese pacifico, pluralista e cosmopolita. Poi, invece… Altro non ci fu contro il jazz. Del resto, anche nella musica leggera, il capo della censura, Criscuolo, vedeva pericoli e allusioni ovunque. Come in “Crapa pelada” (1936), di Kramer, che il popolino credeva alludesse al lucido cranio del Duce, o in "Maramao, perché sei morto?" (1939), che Panzeri dovette provare di aver composto prima della morte di Costanzo Ciano; mentre si tratta di un'antica filastrocca popolare che già nel 1831 era costata l’arresto da parte della polizia pontificia dell’incauto nottambulo che l’aveva canticchiata dopo i funerali del Papa, come si legge in un sonetto romanesco (G.G. Belli, Er canto provìbbito, 11 febbraio 1833). La gustosa vicenda, che smentisce alcuni luoghi comuni e coinvolge curiosamente gatti, censura pontificia e censura fascista, è raccontata in questo articolo.
Altro non ci fu contro il jazz. Del resto, anche nella musica leggera, il capo della censura, Criscuolo, vedeva pericoli e allusioni ovunque. Come in “Crapa pelada” (1936), di Kramer, che il popolino credeva alludesse al lucido cranio del Duce, o in "Maramao, perché sei morto?" (1939), che Panzeri dovette provare di aver composto prima della morte di Costanzo Ciano; mentre si tratta di un'antica filastrocca popolare che già nel 1831 era costata l’arresto da parte della polizia pontificia dell’incauto nottambulo che l’aveva canticchiata dopo i funerali del Papa, come si legge in un sonetto romanesco (G.G. Belli, Er canto provìbbito, 11 febbraio 1833). La gustosa vicenda, che smentisce alcuni luoghi comuni e coinvolge curiosamente gatti, censura pontificia e censura fascista, è raccontata in questo articolo.






 Nulla più di individuale, di personale. Vi ricordate, quando eravamo giovanissimi, che "schifo" che ci faceva, a noi romani, l'Altare della Patria o Vittoriano? Ci avevano convinto i professori della facoltà di architettura di Roma, tutti contestatori snob antiborghesi. Gli stessi che progettavano e costruivano i serpentoni di cemento armato di Corviale - invivibile - solo per il gusto d'una aristocratica "linea" grafica, d'un disegno originale, ma poi loro abitavano ai Parioli o al Ludovisi.
Nulla più di individuale, di personale. Vi ricordate, quando eravamo giovanissimi, che "schifo" che ci faceva, a noi romani, l'Altare della Patria o Vittoriano? Ci avevano convinto i professori della facoltà di architettura di Roma, tutti contestatori snob antiborghesi. Gli stessi che progettavano e costruivano i serpentoni di cemento armato di Corviale - invivibile - solo per il gusto d'una aristocratica "linea" grafica, d'un disegno originale, ma poi loro abitavano ai Parioli o al Ludovisi.